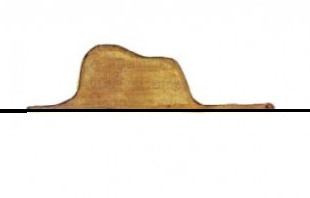a gabriella
B. si alzò, bruscamente. Non andava, proprio non andava. Per fortuna aveva la soluzione a portata di mano, e questo pensiero bastava a mitigare la sua agitazione.
L’ultimo capitolo del libro sarebbe restato un foglio bianco, tanto lavoro per nulla se non fosse riuscita a trovare in quel clima di avventura, la regola che tutto legava, che aveva più volte, inutilmente, cercato. La risposta stava tutta in A. Lui sapeva, lui aveva girato il mondo. Sarebbe stato nel contempo sincero e generoso nel proporre spunti e suggerimenti.
Li separavano tre chilometri in linea d’aria, poca cosa, se quei tre chilometri non fossero stati attraversati dalle correnti più forti e minacciose del mediterraneo. Scilla e Cariddi, persino i testi classici ne raccontano anfrattuosità e perigli. Niente da fare nemmeno per i mezzi più moderni. I tre chilometri diventano sette per qualsiasi natante quando sceglie l’equilibrio tra la via più veloce e, nel contempo, meno rischiosa.
Reggio e Messina, due città – la stessa città – uno scherzo della natura. Un confine naturale che dilata lo spazio fisico in virtù degli elementi che lo dividono. Per andare da Reggio a Messina (o vice versa) ci vogliono realisticamente due ore. In condizioni diverse la stessa distanza potrebbe essere percorsa, a piedi, in poco più di trenta minuti.
B. era tranquilla. Erano le due del pomeriggio, un caldo pomeriggio di luglio, e l’ultima corsa partiva alle undici. Tutto il tempo per fare una doccia e andare al porto. Per quanti turisti ci potessero essere avrebbe senz’altro trovato un posto per la sua auto in uno dei tanti traghetti (ne parte uno ogni venti minuti) e sarebbe arrivata a Messina in tempo per vedere A.
Trovare A., poi, non era un problema. Passava le sue giornate al bar Universo e le serate al bar del porto, quando era a casa e non preso a rincorrersi per altri mari. E ora A. era a casa, in attesa del certificato di invalidità permanente che gli avrebbe permesso di partire per un lungo, forse il più lungo, viaggio.
B. ordinò i fogli sulla scrivania, mise le ultime bollette arrivate nel cassetto, prima o poi si sarebbe occupata anche di loro. Il suo programma era semplice, una doccia, per costruire un’ultima barriera alla calura estiva, e poi via, verso la fine di quella che era sembrata una interminabile storia.
Così mentre era sotto l’acqua B. ripensò all’ultimo anno. Agli sforzi compiuti per portare avanti quello che per i più sarebbe restato un modesto racconto, interessante, piacevole o forse noioso ma che in realtà conteneva più cose di lei di quanto chiunque altro potesse immaginare. Pensò agli amici, ai pochi amici, cui aveva timidamente mostrato le bozze dei primi capitoli. La fiducia di qualcuno, l’incomprensione di qualcun altro, le risate beffarde di F., sempre pronto a rimarcare la sua diversità. Poi quel weekend in campagna con i suoi, oramai anziani, un po’ appesantiti dal peso degli anni ma in qualche modo più lucidi che mai. Quel fine settimana l’aveva segnata profondamente. Le aveva fatto nascere un inusitato desiderio di finire il racconto e di darlo alle stampe. Sarebbe stato un tentativo, l’ennesimo forse, di aprire una porta verso l’esterno. Di raccontarsi per quello che era, senza riserve, di permettersi, seppur sotto le mentite spoglie della fantasia, di regolare alcuni conti col passato, riempiendo dei buchi che nessuna parola detta avrebbe saputo colmare. E poi la stasi, l’imbarazzo, il riprendere fiato fino a fermarsi di nuovo. In ultimo intravedere la fine e sentire di non riuscire a farcela da sola. Le telefonate con A. sempre disturbate, interrotte dal vociare continuo del bar Universo. La partenza di A., Madagascar era stata l’unica parola che B. era riuscita ad afferrare in quella impossibile comunicazione, e la pressante attesa del suo ritorno.
Nel frattempo aveva finito la doccia, si era asciugata i capelli, rivestita e stava lavandosi i denti quando sentì squillare il telefono. Fu più forte di lei. Una tensione nascosta, il timore che fosse A., che chiamava per comunicare che aveva già ritirato i documenti e stava per partire per chissà quale destinazione. Uno scatto solo un po’ più brusco del giusto, la mano che non segue il movimento del volto e d’improvviso l’inferno si materializza in quella piccola inutile otturazione di amalgama che, ignara, casca silenziosamente a terra.
Il nervo era scoperto, e con lui tutta B. Si sentiva esposta alle più lancinanti torture. Nessun pensiero/un solo pensiero: le stavano trapanando il cervello.
Ci mise almeno dieci minuti a riprendere coscienza. Si trovò fradicia di sudore, con la camicia sporca di un misto di dentifricio, saliva e quel maledetto colluttorio verde che sul bianco non poteva passare inosservato. Il trapano non aveva smesso di stuzzicare sadicamente il suo apparato neuronale, brividi freddi la coglievano a tratti, ma, avrebbe detto il professor Freud, il suo SuperIo aveva di nuovo un minimo controllo della situazione.
Si buttò sul telefono, sfogliando contemporaneamente quella stupida rubrica telefonica che non aveva mai avuto bisogno di usare, regalo di una cugina, in cerca del numero di D.
D, come dentista.
Furono una manciata di secondi e l’agitazione non le permise di rendersi conto che attorno a lei qualcosa stava cambiando. L’aria si era fatta spessa, il cielo improvvisamente nero come può capitare nelle calde giornate d’estate. Aveva già composto metà del numero che qualcosa la costrinse ad accorgersi che in quel breve frangente il mondo era diventato diverso. Il rumore fu terribile. Una bomba, pensò, e che ne sapeva lei di bombe? Il telefono cade a terra e con lui la rubrica. Improvvisamente la pioggia inizia a scrosciare. Torrenziale.
Ci sono momenti in cui un temporale estivo porta gioia e refrigerio, altre volte suscita sgomento e risveglia le paure più nascoste. In quel momento, per B., il tuono riuscì solo ad allontanare ulteriormente la speranza di ricacciare quel maledetto nervo di molare nella sua tana.
Non si perse d’animo. Lentamente raccolse l’apparecchio e la rubrica telefonica. Mentalmente riuscì a maledire sua cugina che gliela aveva regalata senza la seppur minima considerazione di quanto piccolo fosse lo spazio tra l’una e l’altra riga. Con gli occhi gonfi di lacrime ritrovò il numero e lo compose.
D. rispose dall’altra parte dell’apparecchio.
Mentre il nervo continuava a raccontare, a modo suo, la sua esperienza del mondo, fu come se gli angeli avessero iniziato a cantare. Ma cosa ne sapeva B. degli angeli? Nessun appuntamento, urgenza, un dialogo tra sordi. D. l’aspettava nel suo studio dentistico dopo dieci minuti.
Dire e fare fu uno scherzo, il SuperIo di B. prese il dottor Freud per la collottola, lo mise bello bello seduto a guardare e la portò giu per le scale, e quindi all’auto e poi via dei Gelsomini, piazza Roma, viale Umberto I, tutti i semafori rispettati, la precedenza lasciata, persino la vecchia col nipote che tornavano da scuola salutati con un sorriso, il miglior sorriso del suo repertorio. B. era una vera macchina da guerra.
D. fu, come sempre, gentile, pratico ed efficace. L’appellativo di ‘mani di fata’ con cui tutti i pazienti dello studio segretamente si riferivano a lui riusciva malamente a descrivere il fisico secco e allampanato, il naso camuso e l’aria perennemente distratta del dottore che, in effetti, di ‘fatato’ aveva solo i modi e le mani. Venti minuti, un’iniezione, un altro po’ di amalgama, cinquantamila lire e gli angeli poterono librarsi in volo, portandosi via il canto e lasciando libera la strada per il porto.
La pioggia aveva smesso di cadere ma la città mostrava, vistosi, i segni dell’acquazzone. B. considerò il suo aspetto e, pur ritenendolo sufficientemente riprovevole, decise che non sarebbe tornata a casa ma che si sarebbe piuttosto diretta immediatamente all’imbarcadero. Non sarebbe stata una camicia sporca ad oscurare l’epilogo della sua storia.
La strada per il porto non era lunga, si trattava di raggiungere il lungomare e proseguire, verso sud, per una manciata di chilometri. La pioggia, è vero, aveva congestionato il traffico ma B. si era completamente ripresa e “l’ingorgo post pluviale” aveva nuovamente assunto il suo aspetto abituale.
In coda ad un semaforo B. si ricordò della mappa del quartiere arabo che M. le aveva dato a suo tempo e che ancora teneva nel cruscotto della macchina, curiosa forma di scaramanzia che ora poteva dimostrarsi grandemente utile. Il quartiere arabo di Reggio è, come tutti i quartieri arabi del mondo, composto da un dedalo di stradine e vicoletti, riottosi a qualsiasi toponomastica e rappresentazione grafica. M., in compenso, era il più grande conoscitore della zona, avendoci abitato a lungo ed avendo più volte confuso la sua vita con i contorti meandri che lo attraversavano. Così, quasi per caso o per scommessa, un giorno, diversi anni prima, mentre prendevano una granita al bar della stazione, M. le aveva tracciato lo schizzo del quartiere, come ad occhi chiusi, altro da sé, come ispirato da una forza soprannaturale. “è la piantina più precisa di questo mucchio di case ed interstizi che tu possa trovare” aveva detto. B. decise di crederci, uscì dall’ingorgo e svoltò a sinistra dirigendosi verso il termitaio.
Mentre guidava, tranquilla, inforcò gli occhiali da vista, riesumò il disegno di M. dalle pieghe dell’automobile e lo liberò definitivamente dalla polvere e dalle briciole dei biscotti che per lungo tempo gli avevano tenuto compagnia. La sua mente vagava distratta. Pensare a M. le aveva offerto un po’ di sollievo dalla tensione di quei giorni e cercò di approfittarne ancora. Era M. un amico?, lo era. Solo un attentissimo osservatore, forse solo lei stessa in un momento di distaccata onestà, avrebbe potuto trovarne traccia nel suo libro. Questo non voleva dire che il loro rapporto non fosse intenso, anzi, al contrario, forse era proprio la completezza nella loro comunicazione, seppur frammentata e incostante, che aveva ‘salvato’ M. dalla responsabilità di apparire con maggior mostra di sé nel rimaneggiamento dei suoi ricordi. Un discorso aperto ma senza sbavature non trova spazio altro che in sé e in chi lo usa, è la regola della vita. Le parole spiegano solo ciò che non sanno spiegare, i medici parlano solo del corpo malato, la legge norma le trasgressioni, la poesia descrive il dolore, le scienze ‘esatte’ si ostinano a voler spiegare come gli eventi si sviluppino “fatte salve le ipotesi di continuità, derivabilità e stabilità dei sistemi considerati” … l’uso , più o meno esplicito, dei condizionali, nel lessico della scienza, ne fa un sapere più che altro letterario. La gioia, l’armonia e la salute possono stare ‘con’ ma non ‘nelle’ parole.
Il sollievo dato dal pensiero di M. doveva essere grande. Sebbene avesse smesso di piovere la strada era ancora bagnata e B. non aveva mai avuto abbastanza mani per un volante, un cambio e una cartina. Il professor Freud si era probabilmente rialzato e stava a guardare gongolante, ma cosa ne sapeva lei del professore?. Fu un attimo e il rione Speranza le fu addosso: aveva investito il carretto del pane.
Investire il carretto del pane, in qualsiasi zona di Reggio, è peggio che compiere un sacrilegio. Tutti sanno, ma tutti tutti, dal bambino scaraffone fino al notaio X., che il carretto del pane svolge una funzione indispensabile alla circolazione linfatica dei quartieri della città. Il carretto, o meglio il complesso sistema di relazioni che coinvolge l’attività di distribuzione del pane è quanto permette ai rioni di stare in piedi, di non soccombere di fronte ai “Fornai” di turno o peggio ai SuperMercati. Non solo in termini economici, se fosse stato solo questo non si sarebbero mai visti tanti telefonini in giro, ma, e soprattutto, in termini relazionali. Il carretto sapeva e c’era. Tutti i giorni. Non importa chi lo guidasse né perché ma Lui, l’uomo del carretto (la storia voleva che non ci fosse ora a R.C. alcuna ‘donna del carretto’ ma qualcuno racconta che un tempo ci sia anche stata) Lui girava, costante e metodico, giorno dopo giorno, le strade di una città che cambiava e che restava sempre uguale. Implacabile testimone dei fatti, come il mare che gioca, regolare e apparentemente assente, con la luna e le sue maree, ma più del mare perché Lui le persone le vedeva e con le persone parlava. Se era c’era l’umore persino ci scambiava il pane con qualcosa che delle volte erano soldi ma più spesso frutta, verdura o un rammendo.
Il rione Speranza appena sentito il botto, aveva immediatamente capito che ciò che era rimasto a lungo solo un timore era, alla fine, realmente accaduto, che il flebile legame che teneva unite le celle del termitaio si era incrinato, e con questo non poté che comportarsi di conseguenza. Difendere ciò che si sa e ciò che si ha di sé è la prima regola. E quindi addosso.
All’inizio non ci furono parole possibili. B. non poteva spiegare un fatto, per altro banale, non poteva dire della sua fretta, della sua confusione, dell’appuntamento con A. Non poteva dire che in fondo può capitare, e a Reggio capita sovente, che un mezzo vada addosso ad un altro. Non era un mezzo che B. aveva affondato, nè un danno materiale che aveva procurato. Aveva minacciato la ragnatela. Il rischio era grande.
Qui la macchina da guerra si sedette e divenne una macchina di pace. B. conobbe da vicino tutti i presenti, molto più di quanto il tempo trascorso possa fare immaginare. Una volta noti, solo allora, fu possibile parlare con loro. Una volta noti fu possibile trasformare la disgrazia dell’evento esterno nella fortuna del fatto interno.
Alla fine l’accompagnarono, Lui per primo, fino al porto.
Il tempo è un’entità sfuggente, è la misura della relazione con le cose e le persone. Il tempo si dilata o si restringe come nessun materiale può fare e cercare di afferrarlo è impossibile. B. aveva avuto modo di scontrarsi con il tempo altre volte, e altre volte era stata sua complice nel seguire il lento succedersi degli eventi. Non si stupì quindi troppo di accorgersi, una volta al porto, che il sole era già calato e che il consueto traffico delle più disparate merci, parole, incontri si era spostato, come ogni sera, verso il bar sotto la capitaneria. Non si stupì del cielo nero ma sentì un forte sgomento di fronte alla saracinesca dell’imbarcadero abbassata che mostrava, tronfia di sé, la nota scritta a caratteri maiuscoli, tracciata da una mano decisa a vernice viola: “PER OGGI ABBIAMO FATTO, RICOMINCIAMO DOMANI”.
Pensò immediatamente a quante notti aveva passato di fronte a quelle parole, a quante frasi viziate sprecate a lodarne il significato. Il tempo del lavoro e il tempo del riposo, ma che cosa ne sapeva lei del tempo?
Quelle maledette parole, e quegli stramaledetti discorsi non davano ora spiegazione, né ragione, né giustizia, al fatto più grave e nel contempo più semplice: l’appuntamento con A. era saltato, forse per sempre.
Niente più libro, niente più alleggerirsi dal peso di un anno passato a riallacciare fili lontani di discorsi mai finiti. Niente più B., domani e ancora avanti. A. sarebbe senz’altro partito per il suo viaggio, forse il più lungo, senza lasciare quel pezzo di sé che, finalmente una volta tanto, sarebbe servito a qualcosa, a qualcuno. Niente, solo il niente la circondava, e con questo un senso di grande stanchezza.
e fu dal buio del niente che B. vide muoversi, lenta, la forma di una testa. intuì, come per caso gli occhi gentili dell’uomo che spingeva la sua barca tra una boa e l’altra. vide come con un sapere antico il barchino trovava la sua rotta nella megalopoli del porto, scivolando sull’acqua esperta di navi come se nulla lo facesse meno importante dei natanti ributtanti vele, cime e boccaporti.
Lo vide e capì che il tempo, misura del rapporto tra gli uomini e le cose, non si era ancora per lei stretto del tutto.
B. vede. Ricostruisce la rotta, la macchina di pace è dimenticata, ora B. si fa mastro di vascello per seguire la traiettoria che sta dietro agli occhi gentili. Capito quale è l’obiettivo, B. si butta di gran lena verso il pontile giusto, imbocca la passerella e siede, e mentre aspetta, ancora ansante, si immagina come realmente è, una sconosciuta, sporca di pioggia, di sangue, di colluttorio verde, senza occhiali (ma questo forse solo lei lo può sapere), stanca e con la sua esistenza tra le mani. La camicia un tempo bianca tradisce quello che avrebbe voluto essere un aspetto diverso, è come avere delle scarpe rotte, se sono di marca buona fa più effetto. Lo sa, e nel contempo non vuole saperlo. Non ha mai badato né alle scarpe né al colore della camicia ma teme, o forse sa, che lui potrebbe farci caso e riconoscerla, sporco di pesce e di mare, come altro da sé.
Altro è il sapere che distingue gli uomini, altra è la materia di cui in questi casi chi vuole, e sa, parla. Altro è il racconto in cui B. e l’uomo della barca si sorridono e si capiscono. Uno scambio non commensurabile, un bisogno per un bisogno; il pescato quel giorno era stato poco, il tempo, di nuovo il tempo in aiuto, era tanto, qualche moneta per il servizio e la benzina e come per miracolo B. era di nuovo in viaggio per Messina.
Non ci sono parole per descrivere la traversata, sette chilometri d’acqua contro i tre chilometri d’aria. Quel ponte infinito che è fatto di onde e gorghi. L’isola che si fa terra, mostrandosi poco per volta come una dama settecentesca, una dama fatta di rughe e calli, e vegetazione aspra, e di dossi arsi dal sole, e una città che sa trarre da questo sole più ricchezza di quanto qualunque popolo colonizzatore, per quanto ci abbia provato, le abbia mai saputo dare. Una città che non sa essere stanca di sé perché sa che anche dopo le giornate più calde, dopo i periodi più bui, un po’ di aria ricomincerà ad arrivare, e con lei la speranza.
B. è bagnata dagli schizzi del mare, il barchino ondeggia sospinto dal motore fuoribordo e dal gioco delle onde. Chiude gli occhi e sogna Messina, come è, come la ha sempre conosciuta e come la vedrebbe se la guardasse ora. B. sa che adesso ha già quello che le serve, ha l’avventura e la regola che lega tutte le parole, le sue parole. Il libro è finito. Vedrà A., questo è sicuro, e sarà per chiacchierare con lui, ancora una volta, piacevolmente, del più e del meno.
tommaso 2003